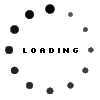Le vacche di Stalin di Sofi Oksanen Ed. Guanda
Anna e Katariina sono madre e figlia. E insieme al sangue le unisce un patto non scritto di colpa, silenzio, paura e vergogna. Colpa perchè Katariina ha sposato un finlandese ed è scappata via dalla natia Estonia e dal duro regime imposto dalla dominazione russa alla fine degli anni settanta, paura di essere scoperta mentre trasporta merci illegalmente nei suoi ritorni in patria, silenzio e vergogna perchè Katariina parla correntemente il finlandese e nasconde a tutti i suoi conoscenti di essere estone. La consapevolezza di essere estranea ad entrambe le sue patrie lacera intimamente sua figlia Anna, che, a causa del furioso controllo sulle emozioni e sulla vita impostole dalla madre sceglie come un destino la bulimia. Anzi la bulimianoressia. “Io so fare sesso senza amare e so amare senza fare sesso. Ma non so fare tutte e due le cose insieme. E sopratutto non so mangiare. Così come c’è chi non sa guidare o non sa le lingue straniere. Non tutti sanno fare tutto.” L’ossesione del peso come una fuga dalla realtà la imprigiona, e la vota ad una reale impossibilità di condivisione emotiva. Il rimpicciolirsi perdendo peso è una specie di rivincita sulla vita difficile che la famiglia di sua madre ha vissuto, dalla deportazione in Siberia subita durante la guerra con la Germania, ai processi sommari durante l’occupazione sovietica, mentre la fame uccide e rende schiavi gli uomini e le donne che la subiscono come parte della condanna inflitta. In Siberia la propaganda sovietica magnifica le famose vacche di Stalin. Ma la vacca di Stalin in realtà è una capra. Parte di questo silenzio subito per salvarsi domina l’anima di Anna, che solo con molta difficoltà riuscirà a sentire di poter dire ” mia madre è estone di nascita” per capire che, quello che era il suo segreto colpevole, non desta nè interesse, nè preoccupazione. Perché le persone sono poco interessate alle tragedie collettive o personali dopo i primi trenta secondi di ascolto.
Non è un libro sulla salvezza ma sulla solitudine senza rimedio. Acuminato come una punta di coltello che spunta fuori da un soprabito. E che per questo lascia stupefatti.
|
|||
Le vacche di Stalin di Sofi Oksanen Ed. Guanda | recensione di Marilena Votta |
|||
|
Copyright © 2025 Mangiaparole – Libreria caffè letterario Roma - All Rights Reserved -
Edizioni Progetto Cultura 2003 S.r.l. Via Manlio Capitolino 7/9 - 00181 Roma
| Capitale sociale 10000 euro Codice fiscale e partita IVA 07832781004
CCIAA Roma REA 1056881 - Progetto Cultura | Privacy Policy Powered by WordPress & Atahualpa |
|||